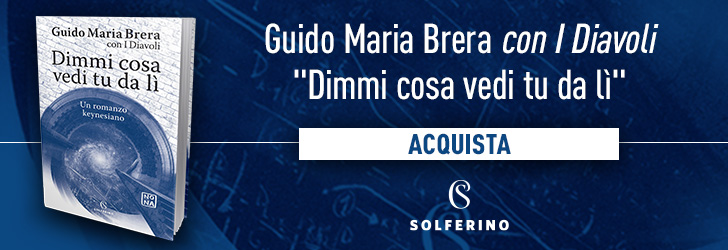Decodificare il presente, raccontare il futuro
RECENSIONE
lun 27 febbraio 2017
SE IL “TRONO DI SPADE” CI INSEGNA LA POLITICA
Da una settimana circa è nelle librerie "Vincere o morire. Lezioni politiche nel Trono di Spade", volume curato da Pablo Iglesias Turrión e uscito per i tipi di Nutrimenti. Se è vero che l’appeal esercitato dagli scenari della serie televisiva "Il Trono di Spade" può essere una spia indicativa dei tempi oscuri in cui siamo costretti, allora la lezione di "Vincere o morire" assume una valenza attuale e decisiva: comprendere a pieno le narrazioni e le costruzioni degli immaginari legati alla rappresentazione del potere, non solo per armarci a livello analitico e interpretativo, ma anche per sperimentare e proporre soluzione concrete di contro-potere e intervento sul reale.
«Covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all.» Thomas Hobbes «L’individuo è un effetto del potere e al tempo stesso, o proprio nella misura in cui ne è effetto, è l’elemento di raccordo del potere. Il potere passa attraverso l’individuo che ha costituito.» Michel Foucault
Da “Where the sun never sets” a “The winter is coming”
Da una settimana circa è nelle librerie Vincere o morire. Lezioni politiche nel Trono di Spade, volume curato da Pablo Iglesias Turrión e uscito per i tipi di Nutrimenti. (Vincere o morire. Lezioni politiche nel Trono di Spade, a cura di Pablo Iglesias, tr. it. di Amaranta Sbardella, pp. 328 – € 18).
Il libro è una raccolta di saggi che sviluppano la loro indagine – una lettura politica, come si vedrà – sulla serie televisiva Il Trono di Spade (Games of Thrones), prodotta dalla Hbo come adattamento, a firma degli ideatori David Benioff e D. B. Weiss, del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. Vincere o morire analizza attraverso le categorie del politico un’opera di fiction che ha spopolato, al fine di comprendere fenomenologia e sottotesti delle narrazioni e delle costruzioni di immaginari legati, in maniera più o meno implicita, alla rappresentazione del potere. In questo senso concentrare il focus su Il Trono di Spade è una scelta ben congetturata: non solo per la vasta portata del suo bacino di pubblico, ma anche perché è un’opera di fantasy, cioè un genere che da sempre sostanzia il proprio serbatoio narrativo con materiali mitici e leggendari, proprio come il potere si è sempre appoggiato, nella storia, a miti e leggende.
«Where the sun never sets» era ancora il tronfio motto dell’Impero britannico agli albori del Novecento, lo stesso impero che diede i natali a J. R. R. Tolkien, grande esponente del fantasy che, attraverso le anabasi e le contese epiche contenute nelle sue opere, volse in letteratura l’alternanza di luci e ombre dello spaccato storico in cui viveva. Ora, più di sessant’anni dopo, con il Trono di Spade, quell’alternanza sfuma in uno scenario post-apocalittico, svuotato di quell’epos che distingueva i vecchi fantasy, in cui non c’è più spazio né speranza per finali catartici o luminose ricomposizioni, come recita il motto della casata Stark in apertura della saga: «The winter is coming», l’inverno sta arrivando.
Scrive Iglesias nella presentazione al volume:
Il panorama di distruzione dell’ordine sociale e politico che la serie mette in scena, e la feroce lotta di una manciata di regni per la conquista del Trono di Spade, minacciato dal collasso dell’intera civiltà, hanno molto in comune con il nostro pessimismo, fin troppo diffuso, e con l’oscuro presentimento che vorrebbe la fine della civiltà occidentale così come oggi la conosciamo. Pessimismo che dilaga ormai in ogni aspetto della nostra vita – spirituale, personale, politico, lavorativo –, specialmente nei paesi più vessati dalla cosiddetta “crisi” finanziaria che ha avuto inizio verso il 2008.
La rappresentazione del potere nell’era della serialità
Opera pop, genere fantasy, e ancora: serialità. Dalla fine dei Settanta in poi, ad Hollywood qualcosa cambia: il cinema smette di narrare solo per immagini e fanno il loro ingresso in sala le saghe. Star Wars, il cui debutto è del ’77, segna uno spartiacque oltre il quale si succede, in maniera progressiva, l’insistenza nel dare una scansione episodica alle opere cinematografiche e ai dispositivi narrativi in esse contenuti, fino ad arrivare, negli anni Zero, al boom della serialità televisiva.
Terziarizzazione e flessibilità del lavoro, avanzamento tecnologico e globalizzazione, riconfigurazione spasmodica degli assetti geopolitici, sono tutti fattori che rendono la realtà sempre più liquida e frammentata e, di conseguenza, la sua trasposizione finzionale deve avvalersi di una sempre maggiore complessità narrativa, che trova il suo congeniale diluente nella serialità.
Tutto questo assume una manifestazione pervasiva con la profonda crisi economica – e politica, ça va sans dire – che si consuma nel primo decennio del XXI secolo. Ne consegue una percezione collettiva del potere e della realpolitik che è oscura e pessimistica, e di cui il successo riscosso dalla serialità narrativa de Il Trono di Spadene è un segno emblematico, sia per il nichilismo ad libitum («Non c’è epilogo, non c’è messaggio, non c’è morale della favola»), sia per la tensione evasiva («Forse il successo di questa serie è legato alle speranze nascoste dei rassegnati cittadini europei») insieme al profondo senso di rivalsa introiettato da una generazione: «Che all’improvviso venga a salvarti quel padre che ti ha ripudiato (il riferimento è a Jeor Mormont, padre di Jorah) o che qualcuno, con i draghi (ovvero: Daenerys Targaryen detta la “Khaleesi”), arrivi a riscattarti dalla mediocrità» (dal prologo di J.C. Monedero).
Tuttavia, la lettura che i saggi di Vincere o morire danno de Il Trono di Spade non è volta solo a riscontare le contraddizioni del momento storico che la serie porta a galla, ma anche e, anzi, allo scandaglio delle strutture teorico-politiche.
Protagonista assoluto de Il Trono di Spade è il “potere”, e i personaggi che si muovono nell’intreccio sono figure subordinate alla sua rappresentazione. In questo senso viene meno la topica struttura, teorizzata da Joseph Cambell, del “viaggio dell’eroe”, perché all’interno della serie ogni personaggio – più un pezzo da scacchi che non una figura eroica – non ha il tempo né le condizioni materiali per portare a compimento la sua epica impresa: o vince, ma rimane sulla scacchiera, oppure muore, e scompare nell’oblio. Ciò che rimane sempre in scena è proprio il “potere”, e la sua continua dialettica con la categoria della legittimità, nello strenuo e vano tentativo di imporsi una volta per tutte.
Dentro la dialettica tra “potere e legittimità” – la cui risoluzione è decisiva per sedere sul Trono di Spade, cioè il trono della legalità – si innescano dialettiche di altro genere, come quella tra “moralità e strategia”: Eddard Stark, uomo morale ma privo di abilità politica; Lord Varys, campione politico privo di scrupoli morali; Petyr Baelish, genio tattico ma al servizio unicamente della sua persona; la (regina) Khaleesi, personaggio estremo e idealista che si emancipa ed emancipa un popolo dalla schiavitù attraverso lo strapotere dei draghi. Di più: ancora connesso alla rappresentazione del potere e, come spiega la “teoria del capro espiatorio” di René Girard, alle modalità con cui esso rafforza la sua possibilità di accentrarsi e consolidarsi, è la paura del nemico esterno. E, ovviamente, anche questo è un elemento chiave che ritorna nella trama del TdS, in quanto i sette regni che si contendono il trono massimo sono protetti e delimitati dalla grande Barriera, oltre la quale incombono le minacce dei “bruti” e degli Estranei.
Machiavelli, Hobbes, Schmitt, Gramsci: lezioni politiche dentro lo script
Lenin diceva che «la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi». Mao Tse Tung sosteneva che «ogni potere nasce dalla bocca di un fucile».
L’ambientazione de Il Trono di Spade, rispetto al momento storico in cui sentenziavano i due rivoluzionari, ha sicuramente i connotati – al netto della sua sostanziale astoricità – di un’era pre-capitalistica ma, armi bianche a parte, i concetti sottesi alle trame della serie sono i medesimi. Essendo il “potere” il vero protagonista della serie, strategie e lotte politiche per acquisirlo sono i nodi cruciali delle trame che innervano la rappresentazione.
In maniera implicita o esplicita lo script è costellato da citazioni e allusioni che rimandano direttamente, o possono essere ricondotte alle teorie politiche di Machiavelli, Hobbes, Schmitt, Gramsci e altri ancora. L’inscalfibile senso dell’onore di Ned Stark conferisce al suo personaggio una caratura morale invidiabile e una miopia politica assoluta, e rispecchia, in altri termini – come spiega Iglesias nel suo intervento Boxe e scacchi tra ombre e spade – la tensione tra etica classica ed etica politica, quella che Machiavelli articolava nei suoi trattati.
Quando Jorah Mormont, leale braccio destro e consigliere della Khaleesi, le dice: «Devi rivendicarlo [in riferimento al suo impavido e decisivo atto di liberazione, ndr], non solo saresti rispettata e temuta, ma anche amata», sta citando – con licenza perifrastica – ancora Machiavelli.
Le teorie formulate da Schmitt sulla guerra intesa come “lotta per il senso”, e sulla dicotomia cruciale tra “amico” e “nemico” che sono alla base della categoria del politico, trovano una loro concreta e credibile rappresentazione nella già citata grande Barriera, eretta a difesa dei sette regni a testimonianza che – come spiega Íñigo Errejon Galván – «nel Trono di Spade le battaglie non sono indipendenti né autonome, ma avvengono in uno scenario che è esso stesso ragione e prodotto di una lotta improntata a edificare racconti condivisi, significati che giustificano gli schieramenti».
E ancora, le parole che Lord Varys rivolge a Tyrion Lannister, «il potere è un’ombra, risiede dove gli uomini credono che risieda», mettono in campo – secondo Iglesias – la riflessione gramsciana sull’egemonia, l’incontrovertibile verità che la lotta politica deve farsi carico anche del «terreno delle ombre», ossia di ciò che può diventare il «senso condiviso di un’epoca». Infine Hobbes, il cui rimando allusivo è impresso mediante allegoria nei primi minuti della puntata pilota, quando gli Stark salveranno una cucciolata di (meta)lupi rimasti orfani della madre e a ogni figlio di Ned Stark andrà un cucciolo, monito inequivocabile da imprimere, all’inizio dei giochi, nella mente e negli occhi dello spettatore: “homo homini lupus”.
Soggettività e violazione della norma narrativa
I personaggi de Il Trono di Spade sono strumentali alla rappresentazione del “potere”. Questa è la tesi fondante di Vincere e morire. Eppure, le diverse caratterizzazioni dei personaggi e il loro agire possono essere letti anche alla luce del problema della soggettività e della costruzione dell’identità.
In questo senso, e come già accennato, si configurano come vere e proprie anomalie rispetto agli assetti canonici degli “eroi” che popolano il mito, la leggenda e – per estensione – il genere fantasy. Ned Stark, eroe dalla tradizionale caratura cavalleresca, è in realtà l’ultimo e decadente esemplare di un mondo destinato a non lasciare il segno, ed anzi a essere surclassato dalla teppa degli “emarginati” che davvero svolgono un ruolo primario nella serie: donne, bastardi, eunuchi, nani, prostitute, invalidi, mutilati, uomini effeminati e donne mascoline, sono insieme soggetti a esclusione sociale e soggetti principali nello svolgimento dell’intreccio.
Le donne, soprattutto. Tanto da poter parlare – lo fanno Cristina Castillo e Sara Porras – di una vera e propria «sovversione femminista», di una costruzione dell’identità in aperta rottura con l’ideologia patriarcale, il cui massimo esempio è rappresentato dalla Khaleesi, personaggio femminile che passa da una posizione di estrema debolezza a una posizione di massimo potere attraverso un itinere di tre tappe tanto cruciali quanto emblematiche.
Il suo primo empowerment nel passaggio da “donna oggetto” a regina dothrak, ottenuto mediante l’affermazione di una soggettività sessuale; la sua sopravvivenza al fuoco – a cui l’uomo sottoponeva le streghe – e il derivante potere esercitato sui draghi; la liberazione dalla schiavitù di un intero popolo femminile e lo strenuo idealismo nel tentare di soggettivarlo.
Porre fine all’inverno
La situazione di “caos” e dissoluzione dell’ordine politico e sociale dei sette troni trova il suo maggiore estimatore – e fautore – nell’astuto, individualista personaggio di Ditocorto che, a detta di Iglesias, incarna a perfezione la frangia neoliberista che – dalla caotica dissoluzione, dal “potere” puro senza leggi, dalla riduzione degli stati a meri strumenti tecnocrati al servizio della catena capitalistica – trae una fondamentale opportunità per portare a termine le proprie scalate di speculazione finanziaria.
Se è vero che l’appeal esercitato dagli scenari de Il Trono di Spadepuò essere una spia indicativa dei tempi oscuri in cui siamo costretti, allora la lezione di Vincere o morire assume una valenza attuale e decisiva: comprendere a pieno le narrazioni e le costruzioni degli immaginari legati alla rappresentazione del potere, non solo per armarci a livello analitico e interpretativo, ma anche per sperimentare e proporre soluzione concrete di contro-potere e intervento sul reale.
Come scrive Wu Ming 1 nella prefazione a Mitocrazia di Yves Citton (Edizioni Alegre, 2013):
«Le storie ci fanno emozionare e le emozioni, lungi dal contagiarla, sono invece un ingrediente essenziale della ragione. Senza rabbia, passione, tristezza e speranza non saremmo in grado di ponderare la più piccola scelta. […] Non sorprende allora che il potere si sia sempre appoggiato a miti e leggende. E forse, per tutta risposta, basterebbe continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto: sgonfiare le favole dei potenti, raccontare altre storie».
Podemos e la Spagna visti da I diavoli, leggi anche:
- Podemos dopo tutto
- Unità e umiltà: diario da Madrid
- Podemos a congresso
- A che punto è la Spagna?
- Il fracaso socialista
NEWSLETTER
Autorizzo trattamento dati (D.Lgs.196/2003). Dichiaro di aver letto l’Informativa sulla privacy.