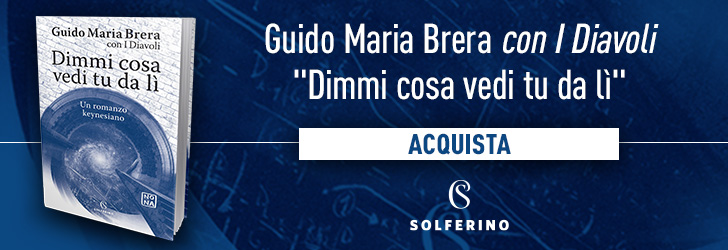Decodificare il presente, raccontare il futuro
MONITOR
sab 8 luglio 2017
FANTOZZI CONTRO IL LAVORO
La myse en abyme del conflitto tra capitale e lavoro è contenuta nella saga fantozziana in forma di psicotica allucinazione kafkiana, dalla quale è impossibile fuggire. Fantozzi è il più feroce inno alla gioia e alla tragedia del non lavoro. È la più mostruosa opera messa in scena contro il lavoro.
La scena è questa. È il finale del film.
In seguito a una clamorosa delusione d’amore con una collega, il protagonista, un oscuro impiegato di una non meglio precisatamegaditta chiede il trasferimento ad altro ufficio. Qui incontra un certo Folagra – “intellettuale di estrema sinistra che tutti avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni” – che gli rivela una nuova ragione di vita: la politica. Allora s’immerge in uno studio matto e disperatissimo dei testi sacri della contestazione che in quegli anni – il film è del 1975 – sta dando l’assalto al cielo della crisi in Europa.
Alla fine, “dopo tre mesi di letture maledette […] vide la verità, o meglio, s’incazzò come una bestia”, contro “il padronato e le multinazionali [che] per vent’anni mi hanno lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro erano buoni”.
Avuta la rivelazione, la mattina dopo si presenta al lavoro e lancia un mattone contro le finestre dell’azienda.
Qui c’è già tutto. A partire dal gesto comico. Il protagonista è un corpo flaccido, mostruoso, incapace di movimenti propri, costantemente sballottato sulle onde dei luoghi del lavoro – l’ufficio, il corridoio, la mensa – dal moto perpetuo della produzione. Gli occhi bassi, lo sguardo terrorizzato, le labbra cadaveriche, i movimenti impercettibili di mani che non superano mai l’altezza del gomito e gambe che non fanno mai il passo più lungo del ginocchio, costruiscono una maschera tragicomica degna dei grandi maestri.
Come scriveva Michail Bachtin in L’opera di Rabelais e la cultura popolare, la maschera sovversiva del corpo comico è in perpetua “transizione”. È una “metamorfosi, in violazione dei confini naturali” del corpo stesso. E quella dell’impiegato lo è magistralmente in antitesi. In sottrazione.
I movimenti controllati portano il corpo sfruttato in prossimità dell’immobilità. Alla plasticità di Charlie Chaplin imprigionato negli ingranaggi contrappone la stasi dell’impiegato compresso dalle pratiche burocratiche, alla meccanicità incapace di comprendere il moderno di Jacques Tati la fiacchezza incapace di vivere e desiderare del contemporaneo.
La stessa clamorosa delusione d’amore è la negazione assoluta della capacità di godere, la mortificazione del desiderio nell’era del godimento libero.
Il gesto comico del protagonista è un mattone lanciato contro le vetrine dello status quo e al tempo stesso contro ogni tentativo di superarlo.
È l’abbattimento brechtiano della quarta parete, quando – attraverso il gesto “citabile” – si aliena lo spettatore per interrogarlo su quale sia la realtà sociale che ha prodotto il film e, soprattutto, sta producendo lo spettatore stesso.
Il linguaggio
Poi c’è il linguaggio.
Le iperboli in corsivo nel testo. Mostruoso, galattico, pazzesco, strepitoso, clamoroso.
Eccessi, enfatizzazioni che rovesciano il discorso comune e, insieme allo sproloquio infantile (merdaccia, coglionazzo) e ai congiuntivi sbagliati (vadi, batti, venghino), ribaltano il comune sentire estetico dell’epoca. E lo colpiscono al cuore quando queste iperboli, di per sé innocenti, sono in realtà aggettivi giustapposti in maniera discordante a sostantivi di solito accompagnati ad altro – clamorosodiventa il colbacco, mostruosa la vacanza, galattico il megadirettore.
Il montaggio dialettico lavora tanto sul linguaggio visibile della pellicola quanto sull’assurdo della sintassi e della grammatica, nella migliore tradizione dei giullari e delle maschere: ancora Chaplin, Peter Sellers, Dario Fo. Lo stesso aggettivo deonomastico fantozziano, ci ricorda Stefano Bartezzaghi, è introdotto nei vocabolari della lingua italiana nel 1977, il più sovversivo tra gli anni del secolo breve.
È la mostrificazione al lavoro (sul corpo e) sul verbo.
Il ritorno a quel linguaggio proibito del carnevale che, sempre secondo Bachtin, porta alla “temporanea liberazione dalla verità data e dall’ordine stabilito”, a un piano di “sospensione delle gerarchie, delle norme, dei privilegi e dei divieti”. È il ritorno alla carne, è il verbo che si fa carne.
È pura patafisica linguistica. È l’invenzione di una realtà altra, non quella che lo spettatore si immagina, ma quella in cui lo spettatore esiste per davvero. Quella vera.
La messa in scena
Infine c’è la messa in scena.
In pochi minuti ci dice tutto. Quando il protagonista si trasferisce abbandona la sua solita postazione – un sottoscala che è il polifonico sottosuolo dostoevskiano – e attraversa un ufficio popolato da molteplici oggetti che si fanno voci. La delusione amorosa impersonata dal vestito rosso fiammante della collega, i numeri e le lettere che non sono quelli di un documento, dichiarazione o cartella da compilare, ma quelli di una battaglia navale che non si sa quando è iniziata e probabilmente non finirà mai. Il collega estremista dipinto con gli occhi tristi di un Garibaldi in gita, con tanto di memorabilia sacri – barba, camicia rossa e foulard – insozzati, come vilipendio supremo alla bandiera del Risorgimento.
Quando, folgorato da Folagra sulla via di Damasco, il protagonista si converte all’insurrezione, lo troviamo improvvisamente con una sciarpa rossa al collo e un eskimo sgraziato su un golfino smunto di lana grigio. La divisa della rivoluzione. È immagine speculare dell’altrettanto conformistica divisa da travet che ha indossato per il resto del film.
Per non parlare del lancio del mattone contro le vetrate. Avviene tra due ali di folla di colleghi interessati, che lo osservano con sguardo entomologico, come insetto in un labirinto, allo stesso tempo sostenendolo e deridendolo. È la stessa scena di quando, all’inizio del film, deve timbrare il cartellino. In ritardo, il protagonista percorre l’infinito corridoio in parata civile, con i colleghi che non lo rialzano stremato per non squalificarlo come Dorando Petri.
Citando se stessa, la pellicola conclude nella maniera più feroce. Dopo aver deriso le norme e le convenzioni dello sfruttamento contemporaneo si fa beffe del conformismo della rivoluzione, degli impiegati della violenza.
L’effetto “risvegliante”
Ma.
Ci sono almeno due ma.
Innanzitutto il film non critica, svilisce, né tantomeno attacca l’estrema sinistra e la rivoluzione. Mette in scena secondo il registro tragicomico, e quindi utilizza il ridicolo per ottenere l’effetto risvegliante del tragico, quello che conosce meglio.
Il film ovviamente è Fantozzi (Luciano Salce, 1975), nato da un’idea di Paolo Villaggio, giullare sublime, comunista eretico, rivoluzionario.
Il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, matricola milleunobis dell’Ufficio Sinistri e protagonista di due libri e dieci film (i primi due diretti appunto da Salce, gli altri otto da Neri Parenti) è la sintesi perfetta della produzione culturale dell’autore.
È la fusione stralunata del temibile Dottor Kranz e dell’impiegato sottomesso Giandomenico Fracchia, i personaggi con cui anni prima ha portato il cabaret surrealista nell’avanspettacolo televisivo dell’Italia del baby-boom catodico.
È la sensibilità poetica di un visionario capace di scrivere versi di tale bellezza: “Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, tra i glicini e il sambuco il re si dileguò”.
Per questo risultano osceni i tentativi di appropriazione post-mortem della maschera Fantozzi in chiave conservatrice.
Un paio di esempi tra i tanti, Silvio Berlusconi (“Hai messo alla berlina per esempio la Corazzata Potemkin”) e Giuliano Ferrara (“Aveva assassinato Eisenstein”) hanno provato a inventarsi un Fantozzi anticulturale, anticonformista, solo e quando il conformismo era essere di sinistra.
Ed entrambi hanno usato il famoso episodio della Corazzata Potemkin (Il Secondo Tragico Fantozzi, 1976).
Anche in questa scena c’è tutto. Il gesto, il linguaggio – cagata pazzesca è nella grammatica generativa di Italia come la dantesca selva oscura o il leopardiano ermo colle – la messa in scena.
Anche qui è la storia di una rivolta disinnescata, fallita, che avviene in maniera speculare nel film (entrambi) e contro il film (entrambi). Come ha fatto magistralmente notare il collettivo Wu Ming “l’episodio del cineforum è un sottile remake del film di Ėjzenštejn, un’allegoria a chiave che ne ripercorre tutti e cinque gli atti”, dove gli impiegati sono i marinai insorti, la sala cinematografica diventa Odessa e la repressione padronale che segue è quella zarista dei cosacchi. La scena è soprattutto “una vertiginosa mise en abyme […] Siamo di fronte a una parodia colta e, al fondo, per nulla anti-intellettuale”.
Ecco possiamo dire che l’intero corpo mostruoso di celluloide di Fantozzi sia una continua e parodistica mise en abyme – la storia nella storia ripetuta all’infinito – dell’esistente, dei suoi gesti e dei sui linguaggi.
Il “secondo” finale
E qui si arriva al secondo ma.
Dopo la scena finale di Folagra c’è un’altra scena finale. Ancora più feroce.
A Paolo Villaggio, Luciano Salce, Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, non interessa terminare il film con una redenzione/rivoluzione impossibile, già di per sé polisemica e adibita ai più svariati piani di lettura.
Vogliono andare oltre ogni possibile interpretazione di un finale consolatorio, alla tipica maniera della commedia all’italiana, e oltre ogni esegesi cinefila di un finale impossibile che ribalta il significato di quello che si vede.
Vogliono essere cattivissimi fino in fondo.
E allora ecco che dopo il lancio del mattone contro le vetrate del capitale arriva il controfinale.
Illuminazione dopo l’illuminazione, appare il megadirettore galattico in persona, “colui che nessun impiegato al mondo era mai riuscito a vedere, correva anzi voce che non esistesse neppure, che non fosse un uomo, ma solo un’entità astratta”.
La “riabilitazione della carne” che Bachtin rivendica come sovversiva nel Gargantua e Pantagruele di François Rabelais trova qui la sua sublimazione contrapponendo il corpo eccessivo di Fantozzi, che per la prima volta agisce contro, al non-corpo del padrone eterno.
E immediatamente, di nuovo, si ribalta la situazione. Il film agisce contro il film.
E nella mostruosa allucinazione che segue il corpo, finalmente senza organi dell’impiegato, quasi capace di sprigionare il desiderio sovversivo, ritorna il corpo vessato nella suprema di tutte le icone anti-materialiste: la crocifissione. Che questa volta avviene in sala mensa.
Dopo un viaggio in ascensore, che è trasmigrazione nell’aldilà del film, la morte al lavoro sul cinema e su Fantozzi, l’impiegato arriva al cospetto del padrone eterno.
E sono di nuovo i gesti.
La contrapposizione tra il corpo di Fantozzi e il corpo del megadirettore galattico è pura celebrazione del corpo dionisiaco – “eccesso della natura”, “grottesco e barbarico” è definito ne La Nascita della Tragedia – del proletario in antitesi alla solennità del non-corpo apollineo del potere.
Ed è di nuovo la messa in scena.
Il bianco accecante, il legno della croce che la produzione di serie ha trasformato in altari e inginocchiatoi e altri strumenti di sottomissione e tortura, il progressivo innalzarsi del non-corpo di fronte allo sprofondare del corpo. Il tutto ripreso con una prospettiva geometrica kubrickiana che fa tabula rasa di ogni possibile identificazione tra spettatore e protagonista.
Ed è di nuovo il linguaggio.
Con la telecamera, arma impropria di sovversione, che costringe alla visione di uno dei dialoghi più terrificanti sulla fine della lotta di classe, o sulla vittoria dei padroni.
Lo dice Warren Buffet, nel 2005. “It’s class warfare, my class is winning, but they shouldn’t be”.
Lo dice trent’anni prima Fantozzi, nel 1975.
Fantozzi: Ma in merito a tutte queste rivendicazioni e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, Maestà?
Mega Direttore Galattico: Ecco, bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà, come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni, fino a che non saremo tutti d’accordo.
Fantozzi: Ma, mi scusi, Santità, ma in questo modo ci vorranno almeno mille anni!
Mega Direttore Galattico: Posso aspettare, io.
Fantozzi: Grazie.
La myse en abyme del conflitto tra capitale e lavoro si trasforma qui in una psicotica allucinazione kafkiana dalla quale è impossibile fuggire. Fantozzi è il più feroce inno alla gioia e alla tragedia del non lavoro. È la più mostruosa opera messa in scena contro il lavoro.
NEWSLETTER
Autorizzo trattamento dati (D.Lgs.196/2003). Dichiaro di aver letto l’Informativa sulla privacy.